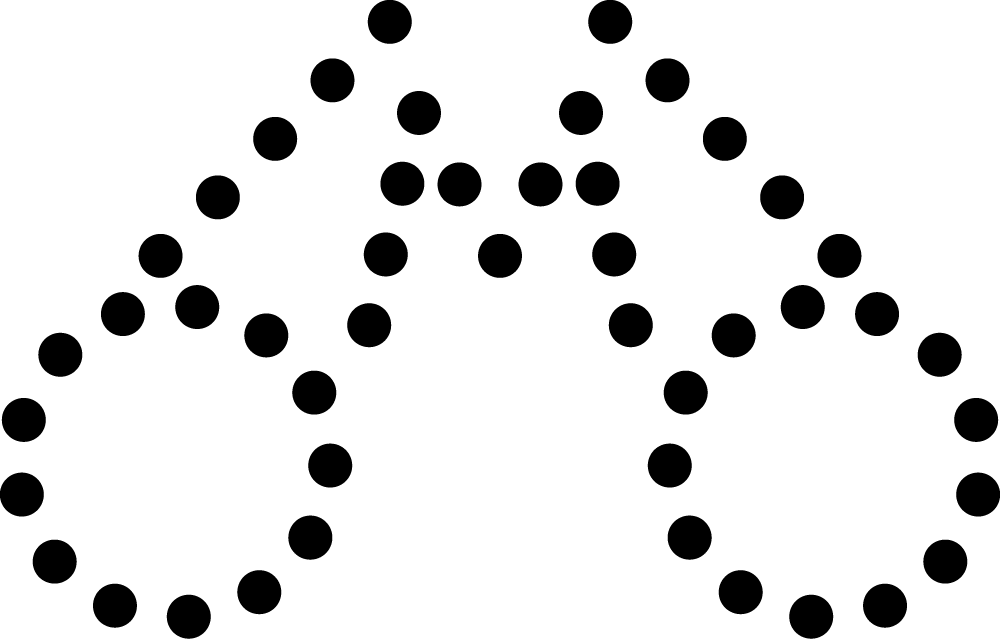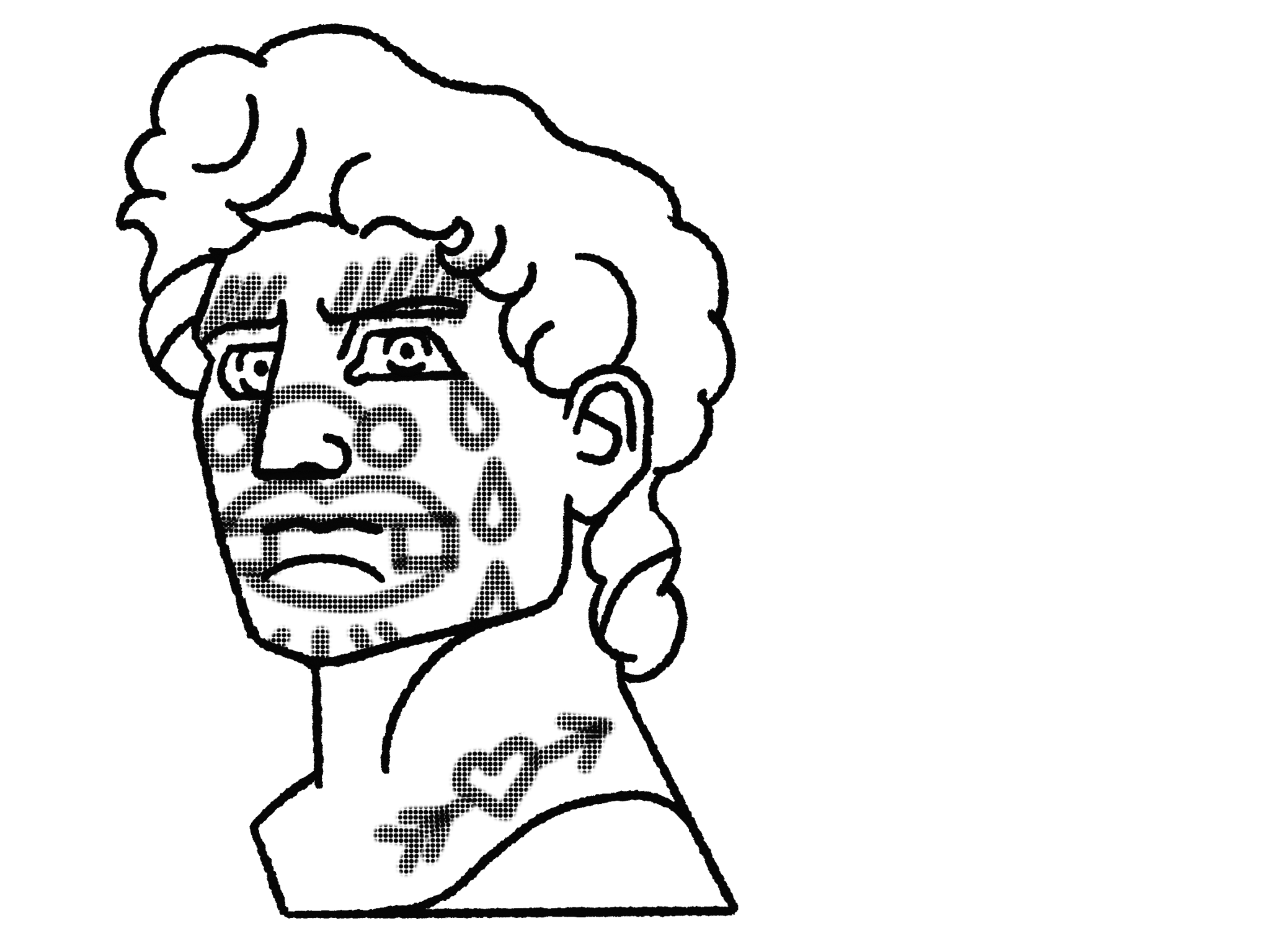Nella nuova edizione di La parola immaginata, Annamaria Testa precisa di non aver attualizzato i testi, scritti originariamente tra il 1987 e il 1988, per aiutare a distinguere tra “tecnologie (che cambiano in continuazione) e processi (che nella sostanza restano in gran parte gli stessi, anche quando si avvalgono di nuove tecnologie)”.
Umberto Eco, invece, in La cultura di massa sotto accusa, si chiede “quante volte il messaggio artistico non viene usato come stimolo evasivo, quante volte lo stimolo evasivo non viene visto con occhio critico e diventa oggetto di una riflessione consapevole?”.
Leggendo entrambi i passaggi, mi sono chiesto: i boni sono una tecnologia o un processo?
Durante il tour promozionale per la pubblicazione del suo secondo libro, Una vita come tante (A little life), l’autrice, Hanya Yanagihara, ha più volte espresso l’interesse per la costruzione di una storia in cui il protagonista, Jude st. Francis, un uomo dal passato costellato di tragedie e continue afflizioni, che in confronto Anna Frank si è fatta una vacanza a Fuerte, non “guarisse mai” (“never gets better”). Nonostante Yanagihara si accanisse sul suo protagonista infliggendogli una sequenza di avvenimenti raccapriccianti in un arco di quarant’anni (abbandono, stupri, abusi fisici e verbali, automutilazione), il suo intento non è mai stato quindi quello di restituire a Jude, e quindi ai lettori, una redenzione da potersi considerare pari o superiore alle sofferenze provate, un “miglioramento” delle sue condizioni che appagasse l’opprimente senso di ingiustizia che aleggia in tutto il libro. Nessuna istituzione, infatti, viene mai a conoscenza dei crimini perpetrati nei confronti di Jude, e quando i vessatori vengono scoperti riescono a eludere l’incontro con la giustizia.
La disperazione di Jude è radicata nel profondo isolamento della propria vita, una vita così irriducibilmente unica nel suo genere da non poter trovare un confronto con un’altra: la sua risolvibilità è negata da un sistema di fondo in cui i termini previsti non coincidono con quelli a disposizione.
Durante gli anni del college a New York Jude incontra poi tre altri uomini con cui instaura, più o meno reciprocamente, un rapporto di amicizia. La rappresentazione dell’amicizia tra giovani uomini di Yanagihara è stato un argomento dibattuto sotto diversi aspetti, come quelli riguardanti la prospettiva di una donna adulta, ma un dibattito il cui argomento principale si basa sull’anteporre l’essere donna a l’essere scrittrice ha già perso il mio interesse più velocemente di quanto potrebbe fare uno che cominci con la domanda “Il defollow è microaggression?”.
No, non è vero, non mi farebbe perdere interesse: la parola microaggression mi fa pensare immancabilmente a microblading e nella mia testa la domanda diventerebbe “Il defollow è microblading?”, che mi fa sempre sghignazzare.
Mi vorrei soffermare piuttosto sul rapporto tra Jude e il suo migliore amico, Willem. Jude e Willem ci vengono presentati come antitetici, sia fisicamente che caratterialmente: l’ambiguità etnica, la predilezione per la riservatezza e la tendenza all’autocommiserazione del primo si rispecchiano ribaltati nell’appartenenza del secondo al canone estetico prediletto dai conservatori statunitensi, che è quello dei tratti germanici (toni chiari di capelli, occhi e incarnato, corpo atletico) e di una predisposizione alla promozione di sé e alla creazione di relazioni, all’apparenza disinteressate, col prossimo. Senza indagare più approfonditamente le storie personali di entrambi o coinvolgere i personaggi e gli intrecci secondari, il contrasto tra i due plasma l’architettura complessiva dell’universo di Una vita come tante: da una parte la vittima, la cui vita è inestricabile dalla sua condizione, da cui è impossibile emanciparsi, e dall’altra il salvatore, il giovane incorrotto, l’incarnazione dell’uomo, nello specifico del maschio, che prende interesse nei meno fortunati e dedica la propria esistenza ad accudirli e ad amarli (il bono è una tecnologia o un processo?).
Willem, un attore inizialmente di scarso successo, si occupa della fragilità di Jude senza mai insistere su quali potessero esserne le origini, offre con generosità la propria autostima all’amico e, successivamente, amante. Yanagihara giustifica l’interesse di Willem per Jude introducendo l’esistenza di un fratello gravemente malato, costretto all’immobilità fin dalla nascita, a cui dedica quasi ossessivamente le proprie attenzioni con un’insistenza che potremmo definire compensatoria per le fortune “naturalmente” ricevute. Willem, quindi, si prodiga per il fratello, e per Jude, come se dovesse ristabilire l’equilibro in un universo che ha concesso troppo da una parte, lasciando sguarniti tutti gli altri.
La vittima non è provvista, nel bene e nel male, dei requisiti necessari per sovvertire l’ordine prestabilito, e qualsiasi tentativo di uscire dai binari delle proprie condizioni comporta solamente ulteriore sofferenza. La vittima ha, per forza di cose, lo scopo di essere salvata, anche prescindendo dalle sue altre qualità.
Mentre in Una vita come tante questa premessa viene portata fino alle sue estreme conseguenze, per cui Jude, dopo una vita di orrende sfighe, decide di suicidarsi, l’unico strumento nelle mani della vittima la cui assolutezza può equivalere all’essere salvati, nel graphic novel prima e adattamento seriale di Netflix poi di Alice Oseman dal titolo Heartstopper, la condizione della vittima sembra allinearsi maggiormente a quella della “damsel in distress” (donzella in difficoltà) caratteristica di un certo filone di fan-fiction degli ultimi vent’anni in cui la protagonista, dall’aspetto confortantemente ordinario agli occhi del mondo, viene notata per le sue caratteristiche intrinseche da un uomo appartenente a una casta separata da quella dei comuni mortali.
Insomma, non la cessa a cui fanno il makeover (che è il trattamento che Anne Hathaway, una gnocca abbondantemente stratosferica, si è beccata a caso non una, ma ben due volte nella sua carriera cinematografica – aiutatemi: ce n’è anche una terza? Vi prego, non ditemi anche una quarta), ma la secchiona goffa moderatamente gnocca interpretata dall’attrice gnocchissima conciata come la personificazione del color tortora, la Manic Pixie Dream Girl senza manic né dream, tendenzialmente il prodotto del self-insertion da parte dell’autrice.
La secchiona goffa moderatamente gnocca viene quindi notata. La parola chiave in questo caso è “notare”: il significato più stretto della parola è quello di “contrassegnare”, di marcare in modo da poter essere riconosciuto, e quindi ricordato, in un secondo momento. Essere notate è quindi per le protagoniste la garanzia di riscatto da una condizione non propriamente di subalternità, quanto di anonimato. Le protagoniste, infatti non vengono descritte come persone comuni, impegnate a condurre vite lineari che procedono senza scossoni, bensì come persone alternativamente comuni. Non c’è nulla di eccezionale in loro: la loro fisicità non corrisponde mai ai canoni di bellezza contemporanei, il loro carattere è ironicamente docile, quasi intorpidito dal grigiore della vita ordinariamente comune, dal logorio eccetera. La donzella non è propriamente in difficoltà, bensì è incompleta, bloccata in un limbo che le impedisce di coltivare le proprie potenzialità latenti. È una donzella che non sa di essere tale.
Una nonzella? Perché no.
Sono dettagli che non si sovrappongono del tutto a uno dei due protagonisti di Heartstopper: Charlie Spring è un ragazzino inglese di 15 anni, magro e impacciato, eppure contraddistinto da interessi peculiari: suona la batteria, ascolta musica convenzionalmente definita alternativa (troviamo affissi alle pareti della sua camera da letto poster di Radiohead, Muse, The Strokes, Daft Punk) (qualcuno più malizioso di me scriverebbe #tuttimaschi, ma io sono apertamente stronzo) ed è molto portato per la matematica.
Anche la cerchia dei suoi amici più stretti non si allinea a quella prevedibile e quasi soporifera delle protagoniste delle fan-fiction descritte poco fa: Tao è un ragazzo testardo e loquace appassionato di cinema, Elle è una ragazza transgenere che si è appena trasferita in un istituto esclusivamente femminile, Aled/Isaac è un ragazzo asessuale che dedica il suo tempo quasi esclusivamente alla lettura. Poi possiamo parlare del fatto che la probabilità che una tale varietà di esponenti della comunità LGBTQ+ si trovi in una scuola a caso della periferia inglese è paragonabile a quella che il Sole dopodomani esploda, ma non facciamoci distrarre da questioni divertenti quando ce ne sono di più pallose di cui occuparci. D’altronde, mio padre mi ha sempre detto: “I film in qualche modo li de’ene fa”.
Dicevo: l’immagine che se ne ricava è più vicina a quella dei misfit, di persone che non si rispecchiano nei ruoli tradizionali della società e che ai margini, ma pur sempre al suo interno, costruiscono sistemi relazionali in cui riconoscersi a vicenda. Non proprio l’indefinibile area grigia delle protagoniste alternativamente comuni.
Per di più, scopriamo che Charlie è reduce dalla rivelazione, suo malgrado, della sua omosessualità un anno prima. Sappiamo che nei mesi precedenti all’inizio della storia, all’istituto esclusivamente maschile che frequenta, viene preso di mira e schernito dagli altri ragazzi, compagni di classe e non. Collateralmente, un ragazzo di nome Ben, venuto a conoscenza dell’omosessualità di Charlie, coglie l’occasione per avvicinarlo e “approfittarsi” della sua vulnerabilità: a condizione che rimanga un segreto, Ben “offre” a Charlie di essere notato, di essere considerato attraente e degno di attenzioni, e organizza con lui degli incontri nelle aule della scuola al di fuori dell’orario di lezione per limonare e passare del tempo insieme – tempo che poi Ben passa sostanzialmente a rompere i coglioni, ma tant’è. È chiaro fin dal principio che il rapporto tra i due sia sbilanciato a favore di Ben, il cui interesse per Charlie ha meno a che vedere con le qualità di quest’ultimo e più con la possibilità di esprimere le proprie pulsioni omosessuali con l’unico studente dichiaratamente gay della scuola. Il salvataggio è in realtà uno sfruttamento di ingenuità e fragilità camuffato da interesse. Un livello comunque della domenica di circonvenzione di incapace rispetto a certi magheggi di Alison DiLaurentis.
Il coprotagonista, Nick Nelson, assolve invece alla funzione del salvatore delle fan-fiction: è uno studente di un anno più grande dello stesso istituto, è un giocatore di rugby dalla corporatura muscolosa e l’aspetto solido e bonario (viene paragonato ad un golden retriever, la razza canina scozzese affettuosa e affidabile per antonomasia – anche un po’ scema, aggiungerei), istintivamente sensibile alle ingiustizie. Quando lui e Charlie vengono assegnati allo stesso banco, la loro amicizia muta rapidamente in infatuazione l’uno per l’altro, e sebbene si potrebbe convenire che sia in realtà Nick il personaggio da salvare (non ha nessuno con cui parlare nel momento in cui acquisisce consapevolezza della propria bisessualità, i suoi amici sono aggressivi e insensibili, le sue abitudini non prevedono incursioni queer), è Charlie che richiede ripetute rassicurazioni di essere, come è innatamente Nick, amabile (il bono è una tecnologia o un processo?).
Sia il graphic novel che la serie tentano di evitare di ricorrere ai luoghi comuni sulla bellezza e la desiderabilità dei personaggi, eppure questi, sia sulla carta che sullo schermo, ricalcano i contorni più consueti degli stereotipi a cui sono assegnati: il salvatore è un atleta, e per forza di cose è forte e “sano”, mentre la vittima è un artista ai margini, e per forza di cose è debole e perfezionabile. Se la confusione adolescenziale di Nick viene accettata così com’è, espressa con candore e tenerezza, la turbolenta incontrollabilità di Charlie è tale solo perché non è stata ancora notata e risolta con l’aiuto di un amore senza secondi fini.
La succitata “turbolenta incontrollabilità” si riferisce ad avvenimenti descritti dalla serie solo nella terza stagione: nel graphic novel, infatti, Oseman rivela ai propri lettori le conseguenze più drammatiche delle persecuzioni subite da Charlie un anno addietro, forse in funzione di un’introduzione alla storia che attirasse per la sua dolcezza. Il bullismo verbale e il senso di inadeguatezza portano Charlie all’autolesionismo e contribuiscono all’emergere dei primi segni di un disturbo alimentare. È solo con l’intervento di Nick e l’osservazione acuta di dettagli percepiti dai vari personaggi come insignificanti ma, a dir la verità, rappresentati come piuttosto evidenti (forse l’unica cosa interessante: puoi essere asessuale e scemo, puoi essere lesbica ed essere completamente concentrata su te stessa e i tuoi problemi: insomma puoi essere un misfit e non capire un cazzo di niente come tutti), che Charlie accetterà l’aiuto di uno specialista. Charlie è in grado di dare un nome alle proprie difficoltà solo a patto che sia Nick ad individuarne la forma, i contorni, ed è in grado di intraprendere un percorso solo a patto che sia Nick ad averne anticipato la direzione.
Una vita come tante prima e Heartstopper poi mi hanno ricordato Le situazioni di lui & lei di Masami Tsuda, pubblicato in Italia da Dynit tra il 1996 e il 2005. Si tratta di un manga che ha conosciuto una grande seppur breve fama grazie all’adattamento in anime diretto da Hideaki Anno (il matto dietro a Neon Genesis Evangelion). Ne Le situazioni di lui & lei due compagni di scuola, Arima e Miyazawa (rispettivamente i cognomi di lui e lei) sono due studenti prodigio: belli, carismatici e intelligenti, sono l’oggetto dell’adorazione e della stima di chiunque li circondi. Frequentano entrambi il primo anno di liceo e concorrono a diventare il primo studente classificato per risultati accademici. Tuttavia, mentre Arima conduce la vita compassata di un aristocratico (figlio adottivo di un’altolocata famiglia di medici), la facciata di studentessa modello di Miyazawa nasconde una realtà opposta: a casa è sboccata e rozza, pigra ed egoista, completamente disinteressata alla cultura e alle arti e già a quattordici anni ossessionata da finanza ed economia (bella la scena in cui, visitando un antico tempio giapponese durante una gita scolastica, Miyazawa si mette a parlare di investimenti in borsa). Quella che per Arima sembra consistere nella naturale competizione tra due individui eccellenti, per Miyazawa è una sfida all’ultimo sangue per dimostrare di poter ottenere tutto quello che vuole fin da quando, suonando il flauto alle elementari, ricevette, da una maestra inconsapevole, delle lodi, e cioè adulazione, quindi fama, quindi potere. Dopo settimane di studio devoto e assoluto raggiunge lo scopo prefisso: essere prima, sconfiggere Arima, dimostrare di avere le capacità per umiliare il principino. Quello che l’aspetta dall’altra parte, però, è una sequenza di avvenimenti inaspettati: Arima si congratula con lei per i suoi risultati, instaura con lei un rapporto di amicizia tra pari, scopre la vera personalità di Miyazawa e, contro ogni aspettativa, comincia a ricattarla, obbligandola a svolgere al suo posto le mansioni di cui è responsabile come leader di innumerevoli attività studentesche. Anche Arima nasconde qualcosa dietro una facciata senza increspature, anche lui è reprensibile come lei.
Quando le loro personalità vengono finalmente allo scoperto, Arima confida fugacemente a Miyazawa di essersi innamorato di lei, e lei stessa si rende conto di nutrire per lui sentimenti affini.
In questo ribaltamento, però, è l’ostinazione di lei a rifiutare qualsiasi sfruttamento al di fuori di quello volontariamente autoimposto a emergere: dopo settimane, annuncia ad Arima di non accettare più il ricatto, di essere disposta a subire un’umiliazione pubblica pur di non sottostare ulteriormente alle sue richieste e ipocrisie. Con il conflitto che ne consegue, i due accettano reciprocamente di accantonare la finzione quotidiana di perfezione, e successivamente Arima confessa a Miyazawa di essere preoccupato che i comportamenti spregevoli che oculatamente cela alla sua famiglia e alle sue compagne e compagni (menzogna, manipolazione, ricatto, sfruttamento) (comunque: bravissimo) possano trovare radici nelle origini dei suoi genitori biologici: persone con un passato di criminalità e violenza che hanno più volte messo a repentaglio la vita di sé stessi e degli altri, ma soprattutto di Arima, abbandonandolo a sé stesso in uno stato di isolamento e incuria nei primissimi anni di vita. Insomma, un macello.
È solo molto più tardi nel manga, e non nell’anime (interrotto bruscamente durante la prima stagione perché l’autrice non si riteneva soddisfatta dal tono eccessivamente comico della trasposizione – pensa quanto si può essere scemi) che Tsuda sviluppa appieno queste premesse. Dopo i primi anni di scuola, in cui diventano una coppia, Miyazawa scopre nella creazione di legami autentici con gli altri, proprio come quello formato con Arima, un obiettivo più appagante, più desiderabile da perseguire della condivisione reciprocamente esclusiva del piccolo mondo accademico con il suo ragazzo. Miyazawa assapora la forza prorompente del proprio, autonomo, agire: mentre pensa di espandere i limiti della sua relazione tra simili, Arima interpreta il suo desiderio di svincolamento, seppure non di negazione, dalle loro identità come un principio di abbandono. Incapace di apprezzare la crescita di Miyazawa, il suo equilibrio psichico comincia progressivamente a peggiorare fino all’emersione di atteggiamenti riprovevoli (la gelosia nei confronti degli amici, la possessività che sfocia nell’aggressione nei confronti di altri uomini) e di violenze (l’abuso di lei, l’autolesionismo). Sarà Miyazawa, nuovamente, a rifiutare di accettare come connaturata alla realtà di lui questa concatenazione di violenze, e a rivelarne il difetto di forma: il motivo per cui Arima ha avuto fin dall’inizio della loro relazione un’ossessione quasi morbosa per non separarsi dall’amore di lei, dalle attenzioni di lei, dalla volontà di Miyazawa di notarlo, il motivo per cui a una sempre maggiore distanza percepita corrispondevano tentativi incrementalmente virulenti di riportarla a sé, non risiedevano nella necessità di lui di essere amato, al contrario. Miyazawa chiede (non afferma, ma domanda) ad Arima se, sotto sotto, lui abbia sempre desiderato amare qualcuno. La loro relazione non vive di una necessità di essere amati incondizionatamente, forse una delle motivazioni più comprensibili, e quindi più usurate dall’immaginario comune, ma della necessità insopprimibile di amare, di esprimersi, di volere bene a qualcuno, o a tutti. L’amore di Arima per il prossimo è stato frustrato, oppresso e sminuito fin dalla nascita, e nella solitudine dell’impossibilità di amare non è mai stato in grado di costruire un alfabeto affettivo che non fosse quello del possesso per prevaricazione.
Ma Arima non è propriamente una vittima, e Miyazawa non è propriamente una salvatrice. Miyazawa offre ad Arima una cornice di significato inedita attraverso cui guardare con gratitudine, affetto e speranza sé stesso e lei, e Arima, lungi dal non essere in grado di riscattarsi, ne comprende l’affinità alle reciproche esistenze, e l’accetta. Quello che si rivelano è quello che sapevano già: vogliamo desiderare tanto quanto vogliamo essere desiderati. Vogliamo essere amati tanto quanto desideriamo amare.
Poi lei diventa un chirurgo plastico e lui un detective. Ci tenevo a scriverlo per risollevarmi l’umore dopo la stracciatura di palle dei precedenti paragrafi.
Riprendo.
Jude di Una vita come tante è una persona la cui salvezza è negata a prescindere nelle intenzioni dell’autrice, mentre il Charlie di Oseman è una persona la cui salvezza è possibile e desiderabile ma solo in quanto tale, una trasformazione da uno stato di sofferenza e inadeguatezza a uno stato di accreditamento da parte di una classe superiore. In Heartstopper, mi è capitato occasionalmente di chiedermi, perciò, se l’innamoramento di Charlie per Nick fosse autentico, per così dire, o se fosse frutto di una pressante ricerca di approvazione (il bono è una tecnologia o un processo?).
Le situazioni di lui & lei sembra suggerire che, nel proteggere fino allo stremo l’immagine che si ha di sé stessi, si perde la possibilità di essere investiti dalla visione altrui. Se nel caso di Jude il rifiuto è categorico (ma anche la condivisione da parte di Willem è limitata, tanto che, alla sua morte, Yanagihara ci rivela che l’ultima visione che ha non è di Jude ma del fratello malato, un livello di morbosità così ricorsivo che, se non fossero ottocento pagine di sventure, mi avrebbe indotto a segnarmi tutti questi passaggi da stronza per capire se, collegandoli, avrei ottenuto “culo” scritto in codice), Nick e Charlie intessono un incessante dialogo di cui il primo beneficia in termini di acquisizione di maggiore consapevolezza di sé, mentre il secondo in termini di cura dei propri disturbi che sarebbe stata impossibile se Nick non avesse in primo luogo notato il problema. Insomma, Nick sarebbe comunque stato bene; Charlie, in balìa di quegli scemi dei suoi amici, mica tanto.
Negli ultimi decenni si è andato a sviluppare un crescente interesse per il sé, ed è per questo che i simboli più rappresentativi della realtà sono l’ossessione inquisitoria anziché conoscitiva della psicologia, la fotocamera frontale e l’algoritmo dietro alla sezione “Per te” su praticamente ogni social network. Sarà anche per questo che, anziché produrre modelli inediti, ci siamo concentrati sul rivisitare, sul rivedere, sul rimodellare, su tutta una serie di ri- che aiutano ad approfondire, a relativizzare, a far fischiare le orecchie di Rihanna, ma al tempo stesso costringono il potere creativo.
Heartstopper racconta una storia di innamoramento tra due adolescenti, e lo fa sì con delicatezza encomiabile, ma anche con una certa inerzia. È il solito dilemma delle storie poco rappresentate: è meglio inventarsi nuovi canoni oppure adottare, e adattare, quelli esistenti? È meglio cercare di affondare la barca della maggioranza oppure, prima, salirci a bordo per farci un giretto? Se ci sentiamo rivoluzionari radicali impegnati a smascherare stereotipi e semplificazioni nei media, se ogni volta che esce un prodotto culturale un po’ pigro, un po’ in malafede, un po’ datato, ci armiamo delle nostre critiche preferite, perché Heartstopper ci va bene così com’è?
Ogni tanto mi capita di ripensare alla recensione di Paolo Pecere del 2014 in cui confrontava Boyhood (film di bruttezza pari solo ad Arrival, mi spiace ma è così) con Il giovane favoloso. In quel pezzo scriveva: “non c’è un gesto di rottura rispetto a quegli stereotipi narrativi, capaci di vampirizzare l’adolescenza, che il cinema-autenticità vorrebbe contrastare con la verità del corpo”. L’impresa decennale di Boyhood non era altro che una trovata, insomma. Una trovata con l’ambizione (la pretesa?) di cambiare qualche cornice di significato sulla realtà che, suo malgrado, finisce solo per appiattire tutto.
(È anche vero che quella recensione ha un vizio di forma: Pecere sostiene che il figlio avrebbe schifato Boyhood – comprensibile – ma sarebbe stato presissimo da Il giovane favoloso – ma figurati. Mi è più facile immaginare che abbia finto di apprezzarlo per guadagnare la paghetta: quale adolescente andrebbe al cinema col padre a vedere Il giovane favoloso rimanendo avvinto da Elio Germano imbolsito che guarda con gli occhio da triglia il cielo recitando La ginestra? Non che invece fosse plausibile rimanere avvinti da Mason in Boyhood che scatta delle foto di merda, eh.)
È facile invece immaginarsi notati, salvati, sollevati dall’onere di doversi occupare di sé stessi, di essere responsabili del proprio desiderare.
Un personaggio secondario di Le situazioni di lui & lei, Maho Izawa, in un volume interamente dedicato alla sua storia, dopo essere stata bruscamente rifiutata dall’oggetto del suo amore, un uomo adulto che ritiene l’interesse amoroso di lei nei suoi confronti solo l’espressione di un desiderio di salvezza da una vita di insopportabile monotonia, pronuncia piuttosto infantilmente questa frase: “solo io conosco il mio cuore”. È un capriccio, ma è anche un briciolo di consapevolezza: quel tanto che basta al personaggio per non dover aspettare di farsi pescare dal cesto dell’anonimato.
Forse, in fondo, ci va bene tutto perché va tutto bene e, anziché utilizzare questo blog per mettere in ordine i pensieri, lo sto usando per inveire alle nuvole perché, come dice Tommaso Giartosio in Autobiogrammatica, ho nostalgia per “un’età in cui il tempo della vita non è ancora stato misurato e non si sente il bisogno di ottimizzarlo”.
Sì, Giartosio intende un’età della vita, l’adolescenza, ma io intendo un’età come periodo storico. Va bene tutto, ma non c’ho mica ottant’anni.